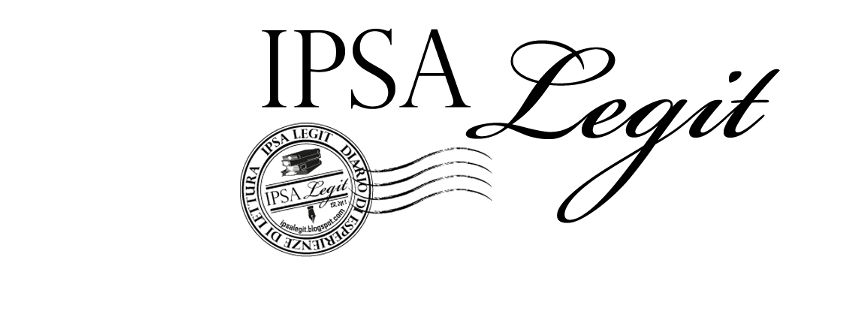Cari lettori, questo è l’ultimo post del 2018, un anno durante il quale posso affermare di aver letto tanti libri davvero belli. Tra questi ci sono La melodia di Vienna di Ernst Lothar, una serie di letture woolfiane (tra tutte segnalo la biografia del nipote Quentin Bell, Virginia Woolf, mia zia), The Master di Colm Tóibín e The Clockmaker’s Daughter di Kate Morton. In questi giorni finali, complici le vacanze scolastiche, ho scoperto altre gradevolissime letture, che mi hanno accompagnata verso e durante il Natale, come One Day in December di Josie Silver (Penguin) e Un delitto inglese di Cyril Hare (Sellerio), che mi ha permesso di rispettare la mia personale tradizione del “leggere in giallo” durante le feste.
Cari lettori, questo è l’ultimo post del 2018, un anno durante il quale posso affermare di aver letto tanti libri davvero belli. Tra questi ci sono La melodia di Vienna di Ernst Lothar, una serie di letture woolfiane (tra tutte segnalo la biografia del nipote Quentin Bell, Virginia Woolf, mia zia), The Master di Colm Tóibín e The Clockmaker’s Daughter di Kate Morton. In questi giorni finali, complici le vacanze scolastiche, ho scoperto altre gradevolissime letture, che mi hanno accompagnata verso e durante il Natale, come One Day in December di Josie Silver (Penguin) e Un delitto inglese di Cyril Hare (Sellerio), che mi ha permesso di rispettare la mia personale tradizione del “leggere in giallo” durante le feste.
Questo librino, che appartiene alla Golden Age della letteratura del mistero, fu pubblicato per la prima volta nel 1951 ed è ambientato proprio nell’immediato secondo dopoguerra. Oltre allo stile limpidissimo, degno di Agatha Christie, si distingue per l’intelligente associazione della vicenda narrata con l’evoluzione della società britannica del tempo, in un paesaggio splendidamente classico (la tipica dimora di campagna menzionata da T. S. Eliot quale caratteristica imprescindibile di una buona detective story) coperto dalla neve durante le feste di Natale. Per restare in tema giallo, ho appena iniziato Morte di un giovane di belle speranze di Jessica Fellowes (Neri Pozza, secondo capitolo della saga dei “Delitti Mitford”).
Finora, tuttavia, la lettura delle vacanze più interessante è stato un saggio, Questa nostra Italia di Corrado Augias (Einaudi). Il libro è un percorso nel tempo e nello spazio, che attraversa le maggiori città italiane per raccontarne le vicende più incisive e intrecciarle sia con la storia del Paese (in particolare il secondo Novecento) sia con la cronaca autobiografica. Contiene riflessioni sullo spirito nazionale, sulla nostra strana relazione con il passato e con le nostre tragedie, sulla scuola, sulla democrazia, sulla politica, sulla nostra lingua e letteratura, e naturalmente sulla nostra geografia, che sembra comprendere e contenere la nostra stessa identità, «nelle città e nei borghi, nelle campagne e nei castelli, nelle pieghe del tempo e nell’ombra di certi passaggi dimenticati. Se si scruta con attenzione, talvolta si riesce a vederla balenare. […] Ogni città italiana, comprese le minime, è uno spazio in cui si è trasfuso e condensato il tempo».
Finora, tuttavia, la lettura delle vacanze più interessante è stato un saggio, Questa nostra Italia di Corrado Augias (Einaudi). Il libro è un percorso nel tempo e nello spazio, che attraversa le maggiori città italiane per raccontarne le vicende più incisive e intrecciarle sia con la storia del Paese (in particolare il secondo Novecento) sia con la cronaca autobiografica. Contiene riflessioni sullo spirito nazionale, sulla nostra strana relazione con il passato e con le nostre tragedie, sulla scuola, sulla democrazia, sulla politica, sulla nostra lingua e letteratura, e naturalmente sulla nostra geografia, che sembra comprendere e contenere la nostra stessa identità, «nelle città e nei borghi, nelle campagne e nei castelli, nelle pieghe del tempo e nell’ombra di certi passaggi dimenticati. Se si scruta con attenzione, talvolta si riesce a vederla balenare. […] Ogni città italiana, comprese le minime, è uno spazio in cui si è trasfuso e condensato il tempo».
Spero che anche il prossimo anno riserverà a me, come a voi, tante indimenticabili sorprese letterarie, che possano farci compagnia tra una stagione e l’altra, regalandoci, come sempre, tanto da imparare e fortissimi moti del cuore. Auguri!